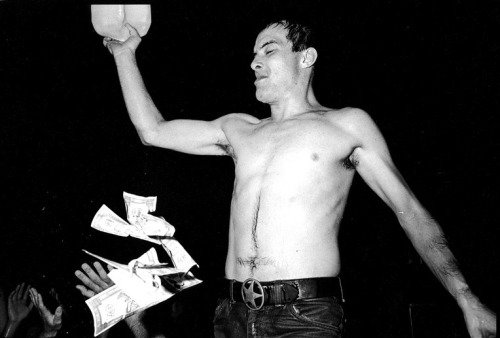Quando dicono che il calcio è morto, io penso a uno che si chiamava Garrincha, con le gambe storte e zoppe. Ma soprattutto penso a loro, le Cholitas. Le madri del Cholo, l’argentino Diego Pablo Simeone, e di tutti i meticci del mondo con le facce da ladro e la volontà di ferro.
Solo chi è Cholo - mezzo sangue – può sapere cos’è l’orgoglio. Ce l’ha impresso nel codice genetico, lo porta appeso nei tratti, nel profilo. Visi da mulo, zigomi schiacciati, nasi incollati alle guance. In America li chiamano “buckwheat“, cioè “grano saraceno”, spighe brune che servono a fare le pagnotte.
Le Cholitas, però, lo sanno bene che il calcio è vivo. E che talvolta lotta assieme a noi. Negli spalti di un qualsiasi stadio dell’universo. Nel cuore di un tifoso qualsiasi che esulta o che maledice la sorte e se stesso. Nella palla qualunque che entra in una qualsivoglia rete e che per un secondo firma l’apoteosi.
Le Cholitas, le donne ibride della Bolivia con la pelle scura e la treccia lunga e nera, lo sanno. Perché giocano al pallone. E’ l’unica squadra che da secoli si tramanda di madre in figlia l’arte del dribbling, della punizione e del calcio d’angolo.
Nel paese sull’altopiano, 3.800 metri sul livello del mare, c’è poco da mangiare. Terra secca con pezzi di pepite d’oro dentro. Ma quando si prova a coltivare il “buckwheat” degli States, il grano saraceno che rende dorata una fetta di pane, le zolle non vogliono saperne. Le Cholitas si spaccano la schiena. Portano acqua alle sementi, al cavolo e al pejote, pregano tutte le Madonne. Scavano, modellano la sabbia dura, gelata d’inverno, arsa d’estate.
Poi, alla domenica, fanno pace con i campi. E giocano. Il prato è di fango. Al posto delle porte ci sono due sacchi pieni di lana, due vasi di fiori, due buste con le pietre dentro. L’unico maschio consentito in gioco è l’arbitro. Gli altri stanno fuori, a guardare.
Dovreste vederle le meticce. Gonne lunghe, rosse. Scarpe rotte. Scarpe improbabili da ginnastica, legate coi lacci alle caviglie. Consunte, zozze. Troppo larghe, troppo strette. Oppure sandali di cuoio aperti, che il piede si rattrappisce solo a vedere i sassi.
E, insomma, le Cholitas si scaldano. E sulle gonne rosse, fino alla caviglia, spesso indossano maglie bianche ed azzurre. Per via del cielo, dicono. Non sono giovani, anzi. Ma il pallone è l’unico gioco consentito, lassù, dove l’aria pesante sconvolge. E più cresce l’età, più si accampano diritti e più è facile trovare un ruolo. Quindi giocano. Giocano nel fango, sotto un sole implacabile tanto è vicino.
Chi vince si porta a casa: a) un montone; b) un pallone; c) una lattina di Coca Cola. Primo, secondo e terzo posto in classifica. E gareggiano. E corrono per il sangue delle gonne rosse, e per il cielo delle maglie. Per uno spicchio di libertà guadagnato spingendo la palla oltre. Oltre le montagne, le rocce, l’orizzonte cupo, le nuvole spesse e il raccolto magro. Giocano, tirano, urlano gol che nella lingua dei meticci vuol dire “ci sono”. E tanto basta per prender fiato e mangiare a morsi il vento, e abbracciarsi come sorelle e ridere di niente.
In Texas, una squadra di professioniste di calcio femminile ha voluto chiamarsi “Cholitas”, in loro onore. Sono certa che le mezzosangue della Bolivia neppure lo sappiano. Ma ripetano il rito del pallone, indifferenti alle nostre regole. Un fischio dell’arbitro ed entri in campo. Tre fischi ed è finita. Sotto il prato che non c’è, si stende come un gatto pigro l’America Latina.
Le Cholitas tornano a casa.
Domani ci sarà ancora da zappare.
Daniela Amenta
(Per Zazie, 2002)