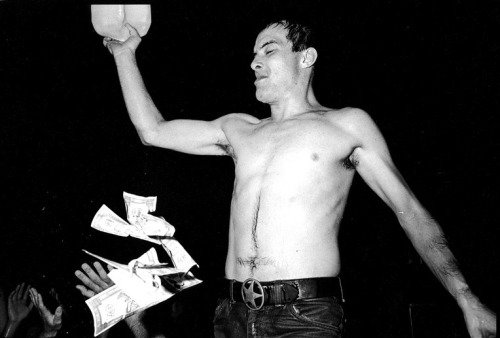E'
lui l'ossimoro. Tutto e il suo contario, soprattutto il bene e il
male, soprattutto la redenzione e la perdizione, l'angelo e il
demonio in una sola anima palpitante, guerriera, nero catrame.
Qualche patto infernale Nick Cave, da Warracknabeal, deve averlo
controfirmato cou una piuma di pavone intinta nel sangue. Ha 56 anni
e sembra più giovane di quando ne aveva 26 nonostante i draghi, le
droghe, la vita misera sull'orlo dei precipizi, le botte date e
ricevute. Sembra un uomo pacificato, Nick. Un uomo che si concede,
si dà, dà “il proprio cuore in pasto al pubblico” come avrebbe
detto Oscar Wilde sfogliando un garofano verde. Lo si capisce subito.
Entra in grande stile con una band sinceramente mediocre, figuranti
stonati rispetto ai veri Bad Seeds, entra nella sala buona
dell'Auditorium di Roma sculettando. Attraversa il palco con falcate
da ballerino, da star. Più alto e più magro di vent'anni fa, sempre
Roma ma al Tenda a Strisce, dove tenne uno show timido, nervoso,
irrisolto.
Oggi no. Oggi è in forma. Vuole amare, farsi amare. Accetta il primo mazzolin di fiori dalla fan in giuggiole, ne bacia un'altra. Palco buio, luci bianche incandescenti. Parte We No Who Ur.
Oggi no. Oggi è in forma. Vuole amare, farsi amare. Accetta il primo mazzolin di fiori dalla fan in giuggiole, ne bacia un'altra. Palco buio, luci bianche incandescenti. Parte We No Who Ur.
Sembra
un concerto, all'inizio. Poi alla seconda strofa di Jubilee Street,
Nick Cave alza il tiro. Il suono è saturato al limite dell'umana
sopportazione, ma così serve. E' suono al calor bianco, è rumorismo
crudele, è il punk che infuria smidollato ed elementare, è il rock
piegato come un Cristo in croce. Un muro di note e tutta la
meravigliosa, coatta, abusata retorica dei quattro quarti trasformati
in marcia funebre e opera erotica. Gli adepti del culto, i missionari
del King Ink, schizzano dalle poltroncine in velluto rosso, dritti
verso il palco. Si alzano centinaia di mani. Il re si fa toccare,
sporge il bacino pelvico, il petto. Ecco, prego, prendetemi. Sono
carezze, baci, urla: una piccola orgia collettiva. Il re si sostiene
con quelle mani. Si tuffa tra quelle mani. Le mani lo sostengono come
un ponte. Sono le mani di Henry Lee, delle donne avute, di quelle
sognate, quelle ammazzate da Barbablu: Deanna, Alice, Sugar sugar
sugar, Lucy, Christina, la moglie di John Finn, Cassiel, Betty
Coltraine. Into my arms, oh Lord.
Ci
sono giorni di inchiostro. E quando arrivano questi giorni, con
mantelli scuri e refoli di vento gelido e brividi, bisogna avere il
coraggio di guardarli in faccia. Avere il coraggio di aprire la
porta, di far accomodare ricordi e manie, e di riascoltarsi un pezzo,
un bel pezzo di vita. La propria. La nostra. La tua. Quando arrivano
i giorni di inchiostro, la musica è del King Ink. re della
nostra
miserevole e fiammeggiante antologia di Spoon River, re e
predicatore, il reverendo Cave armato di doppietta, il satanasso Nick
con camicia nera sul palco che bacia tutti e da tutti si fa baciare:
ragazzine, donne fatte, pischelli in estasi. Love Letter.
L'estasi
arriva con Higgs Boson Blues ed è un pezzo imperativo. La sintesi
del delirio e della rinascita. Cave benedice, maledice. Il trono
della misericordia attende.
“E
in un certo senso spero
di farla finita con questo esame della verità
Occhio per occhio
Dente per dente
E non ho più niente da perdere
E non ho più paura di morire”.
di farla finita con questo esame della verità
Occhio per occhio
Dente per dente
E non ho più niente da perdere
E non ho più paura di morire”.
The
Mercy Seat arriva inarrivabile. Quanto Deanna.
Lui è venuto, lui se n'è andato. Non voleva il nostro amore, non
voleva i nostri soldi. Voleva la nostra anima. Se l'è presa.
Daniela Amenta
28 novembre 2013
28 novembre 2013